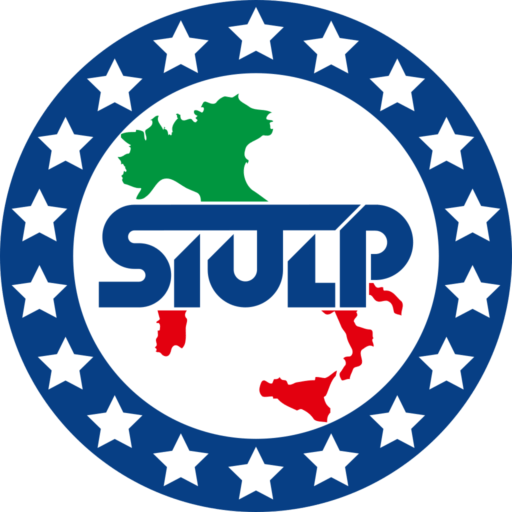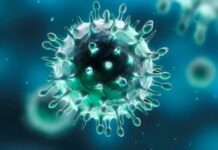Alla convalida del trattenimento dello straniero si applica la procedura ordinaria e non già quella consensuale del mandato d’arresto europeo
La Corte Costituzionale, con la sentenza numero 39, depositata il 10 aprile 2025, ha ritenuto fondata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale – sollevata dalla Corte di cassazione, sezione prima penale – dell’articolo 14, comma 6, del testo unico sull’immigrazione, come modificato dal decreto-legge numero 145 del 2024 – richiamato, per quanto concerne lo straniero richiedente protezione internazionale, dall’articolo 6, comma 5-bis, del decreto legislativo numero 142 del 2015, introdotto dal medesimo decreto-legge –, nella parte in cui rinvia al quarto periodo del comma 5-bis dell’articolo 22 della legge numero 69 del 2005, anziché ai commi 3 e 4 di quest’ultimo articolo.
Secondo la Consulta, la nuova disciplina, nella parte in cui estende al giudizio di legittimità sulla convalida del trattenimento un modello processuale – quale è, appunto, la procedura in materia di mandato d’arresto europeo consensuale – strutturalmente inidoneo ad assicurare alle parti un momento di confronto dialettico scritto o orale, sconfina nella manifesta irragionevolezza.
In linea con la sua consolidata giurisprudenza, secondo la quale la soluzione normativa utile a porre rimedio alla violazione riscontrata deve essere in relazione di prossimità con la fattispecie in scrutinio – e, quindi, in linea con la logica in essa perseguita dal legislatore –, la Corte ha ritenuto che il procedimento di legittimità in materia di mandato d’arresto ordinario costituisca il referente normativo più vicino alla disciplina dichiarata parzialmente illegittima.
La procedura di cui all’articolo 22, commi 3 e 4, della legge numero 69 del 2005 non solo costituisce un modulo processuale agile, semplificato e capace di assicurare la definizione del giudizio di legittimità entro un lasso temporale assai contenuto, ma, offrendo alle parti la possibilità di essere sentite, mantiene integro il nucleo essenziale delle garanzie giurisdizionali alle stesse riconosciute.
La Corte ha, tuttavia, precisato che con l’operata sostituzione normativa ha inteso porre rimedio, nell’immediato, alla riscontrata violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, individuando, «nel massimo rispetto della voluntas legis, la disciplina più vicina a quella originariamente individuata dal legislatore».
Resta comunque ferma la possibilità che il legislatore intervenga in qualsiasi momento per individuare, nell’esercizio dell’ampia discrezionalità allo stesso riservata nella materia in esame, una diversa configurazione dello speciale giudizio di cui all’articolo 14, comma 6, del testo unico sull’immigrazione, «purché tale scelta sia rispettosa dei principi costituzionali e, in particolare, del diritto al contraddittorio e del diritto di difesa».
In particolare, ha concluso la Corte, una revisione delle scansioni temporali di tale procedimento potrebbe divenire ineludibile nel caso in cui un significativo incremento dei ricorsi dovesse rendere non più conciliabile l’estrema concentrazione del rito con la stessa effettività del «diritto al processo in cassazione».
(Fonte: Corte Costituzionale)