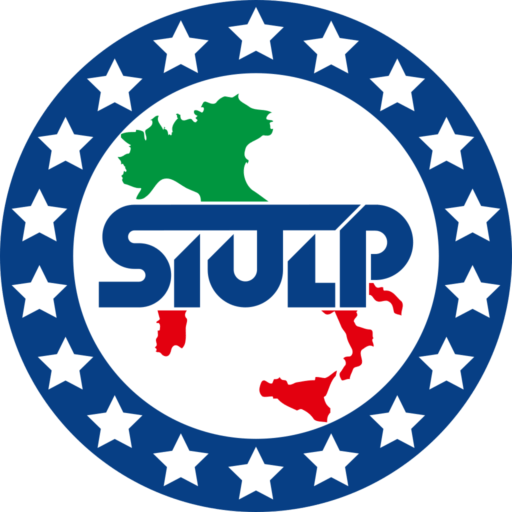Quando si diffondano notizie offensive, false, e comunque non verificate, a nulla rileva che si faccia ricorso a verbi al condizionale, quando l’incedere complessivo delle proposizioni dia a intendere, come accaduto nel caso di specie, a mezzo di espressioni appositamente “confezionate” per accostare l’informazione falsa a fatti veri, la sostanziale volontà di comunicare la notizia diffamatoria e non riscontrata, come, invece, effettiva e fondata.
Il principio è enunciato dalla la Corte di cassazione con la sentenza 14196/2025. Secondo i giudici di legittimità espressioni insinuanti o capziose possono comunque indurre il lettore a ritenere veri fatti destituiti di fondamento ma di indubbio valore suggestivo. Anzi – a giudizio della Suprema Corte – la forza offensiva di questa tecnica narrativa è persino più intensa di quella delle esternazioni caratterizzate dalla forma più semplicemente dubitativa o interrogativa, soprattutto qualora associata a fatti non solo non corrispondenti al vero ma volutamente per mezzo di frasi ambigue, allusive, coinvolgenti e suggestive, e comunque idonee a instillare nella mente dei destinatari il convincimento dell’effettiva rispondenza a verità del fatto formalmente solo “adombrato”. Infatti, a ben vedere, la portata semantica delle parole al condizionale evoca una possibilità, se non addirittura una probabilità di accadimento, che soprattutto nel contesto di un racconto di fatti reali, integra, quanto a dimensione di lesività, un quid pluris rispetto a locuzioni predisposte in forma interrogativa o perplessa.
Nella vicenda di fatto la Cassazione ha confermato le decisioni di merito che dichiaravano la responsabilità penale e civile dell’imputato per il delitto di diffamazione commesso in qualità di autore di uno scritto su un blog in danno di un appuntato della Guardia di Finanza, tacciato nella circostanza come “in combutta coi Narcos” nel contesto di una informazione relativa a un caso di narcotraffico.
Dinanzi alla Corte di cassazione la tesi difensiva si basava principalmente sul fatto di aver accuratamente utilizzato il “condizionale”.
La Cassazione ha ribadito il principio che in tema di diffamazione a mezzo stampa, l’imputato che invochi il diritto di cronaca ha l’onere, in primo luogo, di provare la verità della notizia riportata perché, in difetto della corrispondenza tra fatti narrati e fatti realmente accaduti, è in radice da escludersi l’operatività della causa di giustificazione di cui all’art. 51 cod. pen. Una volta negata la verità dei fatti riferiti, la scriminante potrebbe essere ipotizzata sotto il profilo putativo, ma solo quando il cronista dimostri di aver assolto all’onere di esaminare, controllare e verificare le trame della narrativa, al fine di superare ogni possibile dubbio o perplessità; solo in caso di rigorosa verifica dell’attendibilità della fonte, tanto più approfondita in caso di attribuzione di comportamenti gravi e infamanti a persona determinata, l’attuazione del dovere di controllo può consentire, in presenza degli ulteriori requisiti della pertinenza all’interesse pubblico e della correttezza dei modi e toni espositivi, di ravvisare l’errore percettivo che costituisce il presupposto dell’esenzione della responsabilità a norma dell’art. 59 comma 3 codice penale.
Nel caso in commento, secondo i giudici di piazza Cavour, nessuna ragionevole verifica risultava effettuata, ma neppure seriamente allegata, dall’autore della notizia, i cui motivi di ricorso si limitavano a rilievi “epidermici” sui contenuti della notizia divulgata e ad agitare note di dissenso sulla sussistenza della prova del dolo, quantomeno nella forma indiretta valutata dalle pronunce di merito, con il richiamo sterile di massime giurisprudenziali che, ove non inconferenti, sono state comunque puntualmente rispettate dal corredo espositivo delle decisioni in doppia conforme.