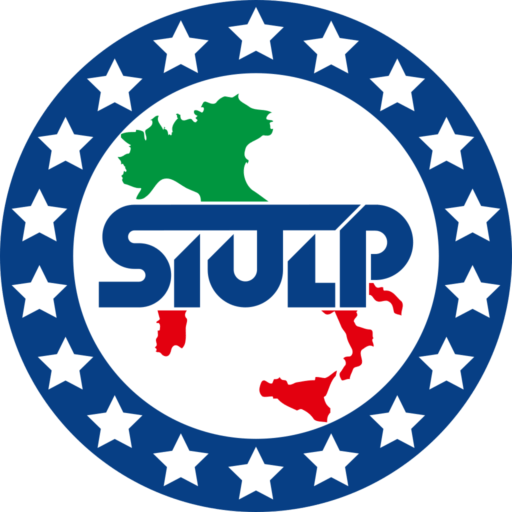Con la Sentenza n. 493/2024 del 21 maggio 2025, il Tribunale di Piacenza, nell’affermare la giurisdizione del giudice ordinario in materia di benefici assistenziali per le vittime del dovere, ha accolto il ricorso, prodotto da un appartenente alle forze dell’ordine, contro il provvedimento che aveva escluso il riconoscimento dello status, di “vittima del dovere”, in relazione alle lesioni permanenti subite a causa dell’infezione da virus Sars Covid-19 contratta nel corso di un intervento effettuato durante l’emergenza Covid-19.
La decisione ha riconosciuto il diritto del ricorrente a essere considerato vittima del dovere, ordinando l’erogazione di benefici economici, tra cui una speciale elargizione e un assegno vitalizio, stabilendo che il rischio affrontato durante l’intervento superava quello ordinario e precisando che il riconoscimento dello status di vittima del dovere non dipende da discrezionalità amministrativa, ma da un accertamento vincolato dei presupposti di legge.
Tracciato il quadro normativo di riferimento, il tribunale ha osservato che il contagio era stato subito riconosciuto come dipendente da causa di servizio sia dal Dipartimento Militare di Medicina Legale che dal comitato di verifica per le cause di servizio.
Invero, i due organi ministeriali hanno entrambi riscontrato il nesso causale tra le lesioni subite dal ricorrente e le circostanze straordinarie ove quest’ultimo si è venuto a trovare nel corso dell’intervento che parte resistente, come detto, non ha mai contestato.
Nella fattispecie il ricorrente, in ottemperanza ad un ordine, era intervenuto in una abitazione affrontando un rischio connesso all’attività di un servizio di pubblico soccorso che andava oltre quello ordinario.
I giudici del Tribunale hanno ricordato che per costante giurisprudenza, il termine “missione” non deve essere inteso come correlato ad un’attività di particolare importanza, connotata da caratteri di straordinarietà o di specialità, ma “ad un’attività che tale non sia e risulti del tutto “ordinaria” e “normale”, cioè, in definitiva, rappresenti un “compito”, l’espletamento di una “funzione”, di un “incarico”, di una “incombenza”, di un “mandato”, di una “mansione”, che siano dovuti dal soggetto nel quadro dell’attività espletata” (Cass., Sez. Un., n. 759/2017). Secondo il Supremo Collegio, ““la particolarità delle condizioni ambientali ed operative”, può sicuramente consistere anche in una situazione venutasi a creare nel corso della missione e non preventivamente determinata”, trovando “questa interpretazione […] conferma nel regolamento di attuazione (D.P.R. n. 243 del 2006), il cui art. 1, lett. c) specifica che per particolari condizioni ambientali ed operative si intendono le condizioni comunque implicanti l’esistenza o anche il sopravvenire di circostanze straordinarie che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
Ai fini dell’integrazione del presupposto delle particolari condizioni ambientali ed operative, occorre, dunque, un’evenienza che non sia contemplata dalla previsione relativa al normale modo di svolgimento di una determinata funzione.
In altri termini, concludono i giudici, in una prospettiva solidaristica ed assistenziale, il legislatore ha voluto assicurare una particolare protezione, di natura economica, a quei soggetti, considerati dalla legge, che abbiano svolto i propri compiti istituzionali in condizioni di particolare rischio per la salute. La protezione accordata dalla normativa in questione, difatti, tutela le forme di esposizione a rischio eccedenti quelle che caratterizzano le ordinarie modalità di svolgimento dei compiti di istituto, quali la partecipazione concreta ed effettiva a missioni o eventi straordinari che espongano i militari a rischi, stress e fatiche non comparabili con quelli propri delle ordinarie attività.