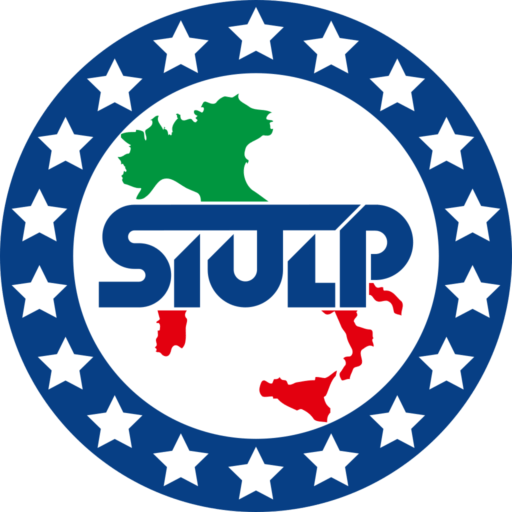L’interpello è disciplinato dall’articolo 11 della Legge 212/2000 (lo Statuto dei Diritti del Contribuente). Si tratta di uno strumento di dialogo diretto e preventivo tra un singolo contribuente e l’Amministrazione Finanziaria. Un cittadino o un’impresa, di fronte a un dubbio sull’applicazione di una norma fiscale a un caso concreto e personale, può chiedere all’Agenzia delle Entrate un parere ufficiale.
La risposta fornita dall’Agenzia è vincolante solo ed esclusivamente nei confronti del soggetto che ha presentato l’istanza (come ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza 9719/2018). Non ha, quindi, un valore generale e non produce effetti nei confronti di tutti gli altri contribuenti.
Proprio per questa sua natura soggettiva e strettamente personale la giurisprudenza amministrativa e il Garante della Privacy hanno variamente affermato che il diritto alla riservatezza del singolo contribuente prevale sul generico interesse alla conoscenza di un terzo, e l’accesso a questi documenti è precluso, salvo rarissime eccezioni.
Peraltro, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, previsto dalla Legge n. 241 del 1990, è un principio fondamentale di trasparenza ma non è un diritto assoluto. La stessa legge prevede dei limiti precisi, che scattano quando la richiesta di accesso va a scontrarsi con altri interessi meritevoli di tutela, primo tra tutti il diritto alla riservatezza.
Un generico interesse alla conoscenza, o il semplice fatto di trovarsi in una situazione giuridica analoga a quella di un altro contribuente, non è considerato sufficiente per giustificare l’accesso a documenti che contengono dati sensibili altrui.
La giurisprudenza amministrativa è stata costante su questo punto. Già il TAR Lazio, con la sentenza 961/2014, aveva escluso l’accesso agli interpelli altrui proprio per la mancanza di questo interesse qualificato. Successivamente, lo stesso Tribunale, con la sentenza 1862/2018, ha ribadito che, per superare il limite della riservatezza, non è sufficiente sostenere che la propria situazione giuridica sia “analoga” a quella dell’altro contribuente.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza 4325/2019, ha definitivamente risolto la questione sottolineando che l’accesso non è consentito quando il documento contiene informazioni di rilievo economico, strategico o fiscale riferite a soggetti terzi.
Un’istanza di interpello, per sua natura, contiene dati estremamente sensibili: informazioni dettagliate sulla situazione patrimoniale, sulle strategie commerciali, sui rapporti contrattuali e sui dubbi fiscali di una persona o di un’azienda. Rendere pubblici questi dati a un terzo significherebbe violare in modo gravissimo la loro privacy.
l’articolo 24 della Legge 241/1990 limita espressamente il diritto di accesso per proteggere la riservatezza di persone fisiche e giuridiche;
l’articolo 5-bis del Decreto Legislativo 33/2013 (il Testo Unico sulla Trasparenza) pone dei limiti all’accesso civico generalizzato proprio in presenza di dati personali o di interessi economici e commerciali di terzi;
il GDPR (Regolamento UE 2016/679), il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, vieta ogni forma di comunicazione di dati personali riferibili a soggetti identificabili, a meno che non vi sia il loro consenso o un interesse pubblico prevalente, che in questo caso non sussiste.
Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha l’obbligo di pubblicare le risposte agli interpelli che ritiene di interesse generale. Detta pubblicazione deve avvenire nel più totale rispetto della privacy. Come disposto da un provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 7 agosto 2018, le risposte vengono pubblicate in forma anonima, omettendo qualsiasi dato che possa permettere di identificare il contribuente istante e solo dopo aver espunto tutti i dettagli personali, economici o commerciali che potrebbero renderlo riconoscibile.
L’unico modo per conoscere gli orientamenti dell’Agenzia è consultare la banca dati delle risposte pubblicate in forma anonima sul suo sito istituzionale.