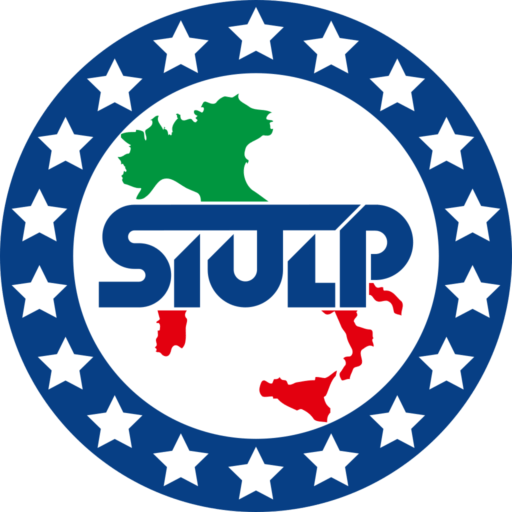Il reato di falsa testimonianza, disciplinato dall’articolo 372 del Codice Penale, punisce con la reclusione da due a sei anni “chiunque, deponendo come testimone davanti a un’autorità giudiziaria, racconti deliberatamente una versione dei fatti che non corrisponde a ciò che si sa essere la realtà, neghi l’esistenza di circostanze o fatti di cui si è a conoscenza o si comporti in modo reticente omettendo volontariamente, informazioni importanti relative ai fatti su cui si viene interrogati”. Questa condotta “omissiva” è considerata grave quanto mentire attivamente, perché priva il giudice di elementi che potrebbero essere fondamentali per la sua decisione” (Cass. Pen., Sez. 6, n. 15102 del 16-04-2025).
Per essere penalmente rilevante, la dichiarazione falsa deve riguardare fatti pertinenti al processo e rilevanti per la decisione. Questo significa che la menzogna deve essere, almeno in astratto, idonea a ingannare il giudice e a influenzare il suo giudizio. La valutazione viene fatta “ex ante”, cioè guardando alla potenziale pericolosità della bugia al momento in cui viene detta, non a posteriori (Cass. Pen., Sez. 6, N. 31393 del 10-11-2020). In altre parole, si è colpevoli anche se il giudice, alla fine, non si lascia ingannare e scopre la verità. Il reato si consuma nel momento in cui si crea un pericolo per il corretto accertamento dei fatti (Cass. Pen., Sez. 7, n. 15161 del 15-05-2020). Una bugia è considerata “innocua”, e quindi non punibile, solo quando riguarda circostanze del tutto marginali, estranee al processo e senza alcun valore probatorio (ad esempio, mentire sulla marca della propria auto se non ha nulla a che fare con i fatti di causa).
Inoltre, la condanna per falsa testimonianza non può basarsi unicamente sul contrasto tra le dichiarazioni rese in fase di indagine (sommarie informazioni testimoniali) e quelle rese in dibattimento (Cass. Pen., Sez. 6, n. 9059 del 02-03-2023). Le dichiarazioni “pre-processuali” possono essere usate in aula per contestare al testimone le sue contraddizioni e per valutarne la credibilità, ma non possono essere usate come prova diretta della falsità di ciò che dice in tribunale. Per arrivare a una condanna, l’accusa deve portare altri elementi di prova (come altre testimonianze, documenti, video, intercettazioni) che dimostrino, al di là di ogni ragionevole dubbio, che la versione detta in aula è falsa e quella detta in precedenza era vera (o viceversa).
Le cause di non punibilità sono principalmente due:
non è punibile chi ha mentito per la necessità di salvare sé stesso o un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello/sorella) da un grave e inevitabile danno alla libertà o all’onore. Questa scusante, però, è rigorosa: il pericolo deve essere concreto e non un semplice timore soggettivo (Cass. Pen., Sez. 6, n. 7006 del 23-02-2021). Questa tutela non si estende agli amici, ai fidanzati o ad altri parenti non stretti;
I prossimi congiunti dell’imputato hanno, di regola, la facoltà di astenersi dal testimoniare. Se il giudice dimentica di avvertirli di questa possibilità e loro testimoniano mentendo, non sono punibili. Se, invece, vengono correttamente avvertiti ma scelgono di testimoniare lo stesso, sono obbligati a dire il vero come qualsiasi altro testimone (Cass. Pen., Sez. 6, n. 28635 del 20-07-2022).
La legge offre una via d’uscita molto importante dalla falsa testimonianza la ritrattazione. L’articolo 376 del Codice Penale prevede che il testimone che ha mentito non è punibile se ritratta il falso e dice la verità prima che il processo in cui ha testimoniato si sia concluso con una sentenza definitiva. La ritrattazione deve avvenire non oltre la chiusura del dibattimento.