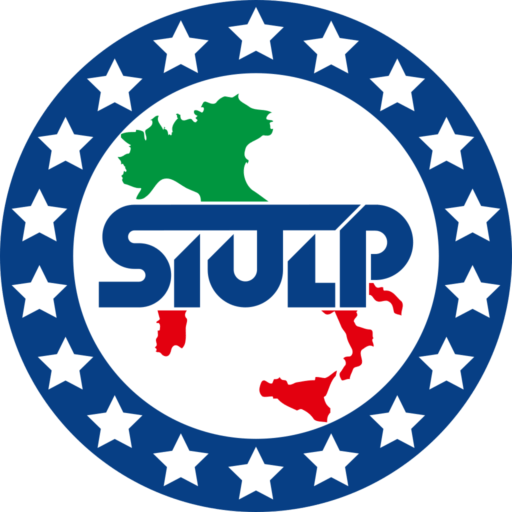Si discute circa la natura (retributiva o assistenziale) dei buoni pasto, questione dalla cui risoluzione discendono alcune conseguenze in materia, ad esempio, di smart working, permessi per allattamento e altro. Il principale punto di riferimento per definire la questione è costituito dalla giurisprudenza.
Il primo argomento su cui si registrano pronunce riguarda il lavoro agile. Invero, soprattutto durante l’emergenza Coronavirus si è posto il problema se il lavoratore in smart working abbia diritto comunque ai buoni pasto.
Sulla questione il Tribunale di Venezia (sentenza 8 luglio 2020, n. 3463) ha escluso, per il buono pasto, la natura di “elemento normale” della retribuzione. Secondo i giudici veneti, il buono pasto è un’agevolazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale (Cass. 16135/2020; Cass. 14388/2016).
L’esigenza di assicurare al lavoratore la fruizione del pasto, dunque, non ricorre nel caso in cui la prestazione lavorativa sia svolta in regime di smart working essendo in tal caso il dipendente libero di organizzare in piena autonomia i tempi di svolgimento del lavoro: i buoni pasto, dunque, non rientrano nella nozione di trattamento economico e normativo, che deve essere garantito in ogni caso al lavoratore in smart working ex art. 20 Legge n. 81 del 2017.
Inoltre, l’articolo 6 del D.l. 333/1992 (convertito con legge 359/1992) escluderebbe, in linea generale, la connotazione retributiva dell’indennità di mensa, in quanto servizio sociale predisposto nei confronti dei lavoratori, salvo che la contrattazione collettiva non ne preveda una diversa qualificazione. Infatti, poiché la disciplina dello smart working è rimessa all’accordo delle parti, a livello collettivo o individuale, è possibile in astratto che l’accordo sindacale preveda che il buono pasto spetti ugualmente, ossia anche nei giorni di lavoro in modalità “agile”.
Altra problematica concerne la spettanza dei buoni pasto alla lavoratrice madre che fruisca dei permessi per allattamento.
Sul punto, la Suprema Corte ha spiegato che il buono pasto non è un corrispettivo obbligatorio della prestazione lavorativa, ossia legato alla prestazione di lavoro in quanto tale, ma un beneficio connesso alle modalità concrete del suo svolgimento orario e, quindi, alla relativa organizzazione: esso, infatti, serve a consentire al lavoratore il recupero delle energie psico-fisiche mediante una pausa da utilizzare per l’eventuale consumazione del pasto, laddove non sia organizzato un servizio mensa.
Dunque, il buono pasto non spetta per il fatto stesso di aver prestato l’attività lavorativa, ma in tanto spetta in quanto la durata della giornata lavorativa ricomprenda anche le ore destinate alla pausa pranzo (Cass. 31137/2019).
Il comma 1 dell’art. 8, d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, infatti, stabilisce che “qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo”.
In sostanza, se l’orario di lavoro ha durata superiore a sei ore il lavoratore ha diritto alla pausa pranzo e di conseguenza al buono pasto. Pertanto, la dipendente che fruisce dei permessi per allattamento e non raggiunge le 6 ore di lavoro effettivo, non ha diritto alla pausa pranzo e, dunque, non matura il diritto al buono pasto: ciò in quanto le ore di permesso godute per tali motivi sono equiparate dall’art. 39 D.lgs. 151/2001 alle ore di lavoro solo ai fini retributivi, mentre non rilevano per il godimento di elementi come il buono pasto, che sono agevolazioni di carattere assistenziale collegate al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale. Inoltre, ciò che conta ai fini della fruizione della pausa pranzo e quindi del riconoscimento del buono pasto sono le ore di lavoro effettivamente prestate (cioè quelle in cui il lavoratore è presente a lavoro) e non anche le ore di permesso per allattamento, in quanto l’esigenza di reintegrare le energie psico-fisiche sussiste solo in relazione alle prime.
Sul punto si è pronunciato anche il Ministero del lavoro che, con risposta a interpello n. 2/2019 ha precisato che sebbene secondo l’art. 39, del D.lgs. 151/2001 i riposi per allattamento debbano essere “considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro”, non bisogna trascurare la ratio dell’art. 8 del D.lgs. 66/2003; la pausa pranzo, infatti, serve a consentire al lavoratore, che effettui una prestazione lavorativa superiore a 6 ore, di recuperare le energie psico-fisiche e non c’è dubbio che a tal fine si debba tenere conto di un’attività lavorativa effettivamente prestata nella quale non possono rientrare le ore di permesso per allattamento.
Da tali premesse discende che, in caso di riposi per allattamento, il buono pasto spetta alla lavoratrice la cui giornata lavorativa si articoli in almeno 6 ore al netto delle ore di riposo per allattamento.