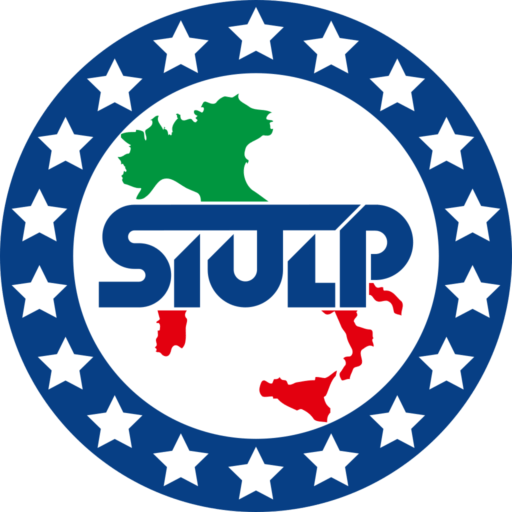L’argomento che questa settimana intendiamo porre all’attenzione dei nostri lettori è quello dei limiti del diritto di critica del lavoratore in relazione all’obbligo di fedeltà quale dovere fondamentale nel rapporto di lavoro dipendente.
L’occasione ci viene fornita dalla Sentenza della Cassazione Sezione lavoro n.7504/2019 del 31 maggio 2022.
La fattispecie oggetto del giudizio riguarda il licenziamento di un dirigente perché, “in contrapposizione con le scelte adottate dagli organi gestionali della società”, aveva mosso censure alla bozza di bilancio ragione per la quale era stato adottato nei suoi confronti un provvedimento espulsivo. Secondo la società datrice “l’evidente sostanziale infondatezza delle censure espresse alla bozza di bilancio corroborava la fondatezza del provvedimento espulsivo adottato”.
Il provvedimento, impugnato e confermato nella fase di merito giungeva al vaglio della Cassazione che lo ha, invece, annullato.
La Sentenza in esame, a prescindere dalla particolarità del caso affrontato in concreto, offre spunti di interesse generale con riferimento al diritto di critica, nelle sue varie accezioni, ed al rapporto in cui si pone con l’obbligo di fedeltà.
Sul tema del diritto di critica del lavoratore nell’ambito del rapporto di lavoro la giurisprudenza di legittimità ha affermato principi ormai consolidati (es. Cass. 1379 del 2019 con ampi riferimenti ai precedenti).
Interessante è anzitutto la definizione del termine “dissenso” individuata dalla Cassazione, letteralmente quale mancanza di consenso, descrittivo, in senso atecnico, della “condizione di chi ha un’opinione o un giudizio diverso rispetto ad altri. In ambito giuridico, il dissenso esprime una volontà difforme, “non conforme” secondo la dizione di cui all’art. 1326, comma 5, cod. civ. e quindi l’antitesi di quel consenso necessario all’accordo delle parti (di cui all’art. 1325 n. 1 cod. civ.). Mentre il consenso si basa su un rapporto di convergenza tra le due volontà, il dissenso rivela la condizione opposta, la non coincidenza tra le due dichiarazioni di volontà”.
Il dissenso, Secondo i giudici di legittimità, “quale manifestazione di volontà, non coincide con le critiche, sebbene il diritto al dissenso possa svolgersi attraverso la formulazione di critiche dirette a spiegare le ragioni della divergenza di volontà e fermo, in tal caso, il rispetto dei limiti di continenza formale e sostanziale individuati dalla giurisprudenza”.
Per quel che concerne il diritto di critica nell’ambiente di lavoro i giudici della suprema Corte muovono dalla considerazione che questo trova fondamento nell’articolo 21 della nostra Costituzione che riconosce a tutti il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. L’art. 1 dello Statuto dei lavoratori riafferma “il diritto dei lavoratori, nei luoghi in cui prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero”, e la necessità di contemperare tale libertà col rispetto dei principi della Costituzione e delle norme dello Statuto medesimo.
Nel rapporto di lavoro, l’esercizio del diritto di critica nei confronti del datore di lavoro deve essere contemperato col dovere di fedeltà posto dall’art. 2105 cod. civ. a carico dei lavoratori, oltre che con il rispetto dei generali canoni di correttezza e buona fede nell’esecuzione del rapporto.
A partire da Cass. n. 1173 del 1986 la giurisprudenza ha individuato regole volte a contemperare il diritto stabilito dall’art. 21 Cost. con altri diritti concernenti beni di pari rilevanza costituzionale, tra i quali, in particolare, i diritti della personalità all’onore ed alla reputazione, stabilendo che: “Il comportamento del lavoratore, consistente nella divulgazione di fatti ed accuse, ancorché vere, obiettivamente idonee a ledere l’onore o la reputazione del datore di lavoro, esorbita dal legittimo esercizio del diritto di critica, quale espressione del diritto di libera manifestazione del proprio pensiero, e può configurare un fatto illecito, e quindi anche consentire il recesso del datore di lavoro ove l’illecito stesso risulti incompatibile con l’elemento fiduciario necessario per la prosecuzione del rapporto, qualora si traduca in una condotta che sia imputabile al suo autore a titolo di dolo o di colpa, e che non trovi, per modalità ed ambito delle notizie fornite e dei giudizi formulati, adeguata e proporzionale giustificazione nell’esigenza di tutelare interessi di rilevanza giuridica almeno pari al bene oggetto dell’indicata lesione”.
La giurisprudenza successiva ha specificato i limiti di continenza formale e sostanziale del legittimo esercizio del diritto di critica, legati rispettivamente alla rilevanza costituzionale dei beni da tutelare attraverso la critica e alla veridicità dei fatti e alla correttezza del linguaggio adoperato (v. Cass. n. 21362 del 2013; n. 29008 del 2008; n. 23798 del 2007; n. 11220 del 2004; più recentemente, Cass. n. 5523 del 2016; n. 19092 del 2018; n. 14527 del 2018; n. 18176 del 2018).
Significativa è la giurisprudenza sul diritto di critica riconosciuto al lavoratore che abbia funzioni di rappresentanza sindacale all’interno dell’azienda e che fa leva, ai fini della copertura costituzionale, anche sull’art. 39 Cost. Al riguardo si è affermato: «Il lavoratore che sia anche rappresentante sindacale se, quale lavoratore subordinato, è soggetto allo stesso vincolo di subordinazione degli altri dipendenti, si pone, in relazione all’attività di sindacalista, su un piano paritetico con il datore di lavoro, con esclusione di qualsiasi vincolo di subordinazione, giacché detta attività, espressione di una libertà costituzionalmente garantita dall’art. 39 Cost., non può in quanto diretta alla tutela degli interessi collettivi dei lavoratori nei confronti di quelli contrapposti del datore di lavoro essere subordinata alla volontà di quest’ultimo. Consegue che la contestazione dell’autorità e della supremazia del datore di lavoro siccome caratteristica della dialettica sindacale, ove posta in essere dal lavoratore sindacalista e sempreché inerisca all’attività di patronato sindacale, non può essere sanzionata disciplinarmente» (Cass. n. 18176 del 2018; n. 7471 del 2012; n. 19350 del 2003; n. 7091 del 2001; n. 11436 del 1995).
Di particolare rilievo è, poi, la giurisprudenza formatasi sulla condotta del lavoratore che denunci all’autorità giudiziaria o amministrativa fatti di reato o illeciti amministrativi commessi dal datore di lavoro.
Numerose decisioni (v. Cass. n. 25799 del 2019; n. 22375 del 2017; n. 4125 del 2017; n. 996 del 2017; n. 14249 del 2015; n. 8077 del 2014; n. 6501 del 2013) hanno affermato che la denuncia di fatti di potenziale rilievo penale accaduti in azienda non possa di per sé integrare giusta causa o giustificato motivo soggettivo di licenziamento, a condizione che non emerga il carattere calunnioso della denuncia medesima, che richiede la consapevolezza da parte del lavoratore della non veridicità di quanto denunciato e, quindi, la volontà di accusare il datore di lavoro di fatti mai accaduti o dallo stesso non commessi, e purché il lavoratore si sia astenuto da iniziative volte a dare pubblicità a quanto portato a conoscenza delle autorità competenti.
Si è infatti escluso che l’obbligo di fedeltà di cui all’art. 2105 c.c., in correlazione con i canoni generali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., possa essere esteso sino a imporre al lavoratore di astenersi dalla denuncia di fatti illeciti che egli ritenga essere stati consumati all’interno del luogo di lavoro, giacché in tal caso si correrebbe il rischio di scivolare verso – non voluti, ma impliciti – riconoscimenti di una sorta di “dovere di omertà” (ben diverso da quello di fedeltà di cui all’art. 2105 c.c.) che, ovviamente, non può trovare la benché minima cittadinanza nel nostro ordinamento (Cass. n. 4125 del 2017; n. 6501 del 2013). Ciò sul rilievo che lo Stato di diritto attribuisce valore civico e sociale all’iniziativa del privato che solleciti l’intervento dell’autorità giudiziaria di fronte alla violazione della legge penale, e, sebbene ritenga doverosa detta iniziativa solo nei casi in cui vengono in rilievo delitti di particolare gravità, guarda con favore alla collaborazione prestata dal cittadino, in quanto finalizzata alla realizzazione dell’interesse pubblico alla repressione dei fatti illeciti.
Da tali considerazioni discende l’affermazione secondo cui l’esercizio del potere di denuncia, riconosciuto dall’art. 333 c.p.p., non può essere fonte di responsabilità, se non qualora il privato faccia ricorso ai pubblici poteri in maniera strumentale e distorta, ossia agendo nella piena consapevolezza della insussistenza dell’illecito o della estraneità allo stesso dell’incolpato (Cass. pen. n. 29237/2010 e, quanto alla responsabilità civile Cass. n. 11898 del 2016). L’esenzione da responsabilità, anche nei casi di colpa grave, si giustifica considerando che la collaborazione del cittadino, che risponde ad un interesse pubblico superiore, verrebbe significativamente scoraggiata ove quest’ultimo potesse essere chiamato a rispondere delle conseguenze pregiudizievoli prodottesi a seguito di denunce che, sebbene inesatte o infondate, siano state presentate senza alcun intento calunnioso.
Proprio la presenza e la valorizzazione di interessi pubblici superiori porta ad escludere che nell’ambito del rapporto di lavoro la sola denuncia all’autorità giudiziaria di fatti astrattamente integranti ipotesi di reato, possa essere fonte di responsabilità disciplinare e giustificare il licenziamento per giusta causa, fatta eccezione per l’ipotesi in cui l’iniziativa sia stata strumentalmente presa nella consapevolezza della insussistenza del fatto o della assenza di responsabilità del datore. Perché possa sorgere la responsabilità disciplinare non basta che la denuncia si riveli infondata e che il procedimento penale venga definito con la archiviazione della “notitia criminis” o con la sentenza di assoluzione, trattandosi di circostanze non sufficienti a dimostrare il carattere calunnioso della stessa.
Nei precedenti citati si è specificato che, a differenza delle ipotesi in cui è in discussione l’esercizio del diritto di critica, in caso di denuncia penale (o amministrativa) presentata dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro “non rilevano i limiti della continenza sostanziale e formale, superati i quali la condotta assume carattere diffamatorio, e, quindi, può avere rilevanza disciplinare, giacché ogni denuncia si sostanzia nell’attribuzione a taluno di un reato, per cui non sarebbe logicamente e giuridicamente possibile esercitare la relativa facoltà senza incolpare il denunciato di una condotta obiettivamente disonorevole e offensiva della reputazione dell’incolpato” (Cass. n. 22375 del 2017; n. 4125 del 2017; n. 15646 del 2003 cit.; Cass. pen. n. 29237 del 2010).
In sintonia con i principi appena richiamati si colloca la legge n. 197 del 2017, recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, che ha dato veste normativa all’esigenza avvertita in ambito sovranazionale e nazionale di incentivare l’emersione di pratiche illegali nel settore del lavoro pubblico e privato, prevedendo canali che consentano la presentazione di denunce o segnalazioni e meccanismi di protezione dei lavoratori dal rischio di condotte ritorsive.
Nel tracciare un equo componimento dei diversi beni di rilievo costituzionale, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che l’esercizio del diritto di libera manifestazione del pensiero, sia che si realizzi attraverso l’espressione di critiche, purché nei limiti di continenza formale e materiale tracciati, e sia che si traduca nella denuncia alle autorità competenti di fatti illeciti, di rilievo penale o amministrativo, purché non di carattere calunnioso, non possa di per sé costituire giusta causa o giustificato motivo di licenziamento. L’obbligo di fedeltà imposto al lavoratore non può spingersi fino al punto da comprimere, oltre i limiti sopra individuati, l’esercizio del diritto tutelato dall’art. 21 Cost. e dall’art. 1 dello Statuto dei lavoratori.
In conclusione, in relazione ai principi enunciati deve escludersi che l’esercizio del diritto di critica, nel rispetto dei limiti già tracciati, e soprattutto la presentazione di una denuncia di illecito penale o amministrativo da parte del lavoratore nei confronti del datore di lavoro possa essere di per sé fonte di responsabilità disciplinare e giustificare un licenziamento per giusta causa, a meno che la denuncia non abbia carattere calunnioso, e senza che rilevino l’infondatezza della accusa e i limiti di continenza sostanziale e formale, dato che l’accusa di commissione di un illecito è per definizione disonorevole. Tali principi comportano, altresì, che “non possa attribuirsi rilevanza disciplinare atta ad integrare di per sé la giusta causa di licenziamento alla condotta di un lavoratore, dirigente ecc. che, senza neanche rivolgersi all’autorità giudiziaria o amministrativa, si limiti a ipotizzare la configurabilità di illeciti penali o amministrativi, mettendo in guardia i soggetti insieme a lui teoricamente responsabili, e ciò faccia nelle sedi e con le modalità specificamente previste dall’ordinamento, come negli artt. 2392 e 2396 cod. civ.”.